Paolo
All’8 Settembre ’43 la forza militare italiana nell’isola di creta era di circa 20.000 uomini (la Div. Siena al comando del gen. Carta): a noi infatti era stata assegnata per il presidiamento una sola delle quattro province in cui è divisa l’isola. Sarebbe stato pertanto assurdo da parte nostra pensare a “resistere”, od a prendere qualunque iniziativa contro i tedeschi, che dopo l’Armistizio nostro c’imposero la resa: i tedeschi a Creta erano in numero di 50.000. I tedeschi raccolsero in determinati “campi di concentramento” i nostri reparti. Il nostro destino sarebbe stato di venire spediti a scaglioni più o meno grandi da Creta ad Atene su ogni nave che i tedeschi avessero in partenza per il Pireo, Da Atene si sarebbe stati poi inoltrati in Germania come “prigionieri di guerra” su tradotte: Atene-Belgrado-Germania, come difatti avvenne. Il numero degli italiani che alla data del 10 ottobre già erano stati imbarcati per il Pireo su forse una decina di navi superavano già 12.000, ed eravamo ridotti a poco più di 7.000 i rimasti. Nel porto di Eraklion (Candia) s’era da una decina di giorni affiancata alla banchina la nave “Sinfra”, di 10.000 tonnellate di stazza, del compartimento marittimo di Marsiglia. Quella nave già nel 1940 i tedeschi l’avevano requisita alla Francia per adibirla più tardi alla navigazione nel mar Egeo. La ormai lunga permanenza di quella nave nel porto era dovuta al molto tempo che aveva richiesto il suo caricamento. Per tutto quel tempo una colonna di automezzi aveva fatto la spola per l’aeroporto, per trasportare sulla nave quella così forte scorta di bombe delle quali all’aeroporto non se ne sapeva più che fare: perduta la battaglia d’Africa, ed occupata dagli anglo-americani ormai tutta la costa settentrionale africana, inutili erano diventati ai fini strategici tutti gli aeroporti di Creta. Quando la sera del 19 ottobre si doveva con carico “umano” completare di quella nave il carico di materiale, la chiglia della nave stava immersa nell’acqua fino alla linea di bagnasciuga, che parecchie migliaia di quelle pesantissime bombe s’erano sistemate in parte nelle sue stive. Per le stive ancora libere si aspettava il nostro carico di zavorra.”
Tratto da: “L’affondamento della nave Sinfra – Donà di San Mauro – Araba Fenice editrice
Quando nacque mio figlio andai a fare quello che fanno tutti i padri, il primo atto burocratico della sua vita, la denuncia di nascita all’anagrafe. Era la prima volta e mi premunii nel modo più logico, chiedendo consiglio a mio padre. Mi disse che non sarebbe stato niente di speciale o difficile, probabilmente mi avrebbero fatto compilare un modulo con le generalità dei genitori, dei nonni e ovviamente la data di nascita del nuovo arrivato. Una sola fu la raccomandazione: “Stai attento a quello che scrivi, perché se sbagli un nome o una data, quell’errore lo perseguiterà per tutta la vita e per lui saranno solo scocciature.”
Così, mentre ero seduto nel corridoio del municipio e aspettavo il mio turno ripensai a quelle parole. Ovviamente con mia moglie avevamo concordato il nome, scegliendolo per prima cosa evitammo quelli dei componenti dell’una o dell’altra famiglia, tanto per non scontentare nessuno, e poi essendoci sposati molto giovani fortunatamente eravamo a corto di parenti defunti. Un'altra condizione unanime fu che il nome doveva essere uno solo e non una sequenza infinita come si usava ancora all’epoca delle nostre nascite. Così andammo a sentimento badando che fosse breve, perché già il cognome sarebbe stato lungo, non troppo usato (anche se dopo quella scelta ci fu una vera e propria inflazione) ma restando sul tradizionale per evitare qualunque critica. Con quello di un evangelista saremmo andati sul sicuro e infatti fu gradito da tutti.
Mio padre invece con me ci andò pesante, e lui si che dovette metterci particolare attenzione, perché di nomi me ne appioppo ben quattro. Il primo fu quello del fratello morto in guerra e fin qui nulla da dire. Il terzo quello di un suo cugino, che mi fece da padrino al battesimo e anche qui ci può stare. L’ultimo quello della Vergine, perché era tradizione in famiglia che a maschi e femmine senza distinzione Maria ci dovesse essere per forza. Ma il secondo, Paolo il protagonista di questo racconto, rimase per un bel pezzo ammantato di mistero, almeno per me che ne ero il portatore. Non solo ma venni a sapere di averlo solo quand’ero adolescente, e che proprio quello ce lo infilò lui di testa sua senza consultare mia madre. Eppure per meritare il secondo posto sul podio prima del padrino di battesimo, e tanta determinazione, doveva pur essere un personaggio importante. Certamente quindi fece molta attenzione, ma era una cosa che da lui ci si poteva aspettare di sicuro. Ma quella lista di nomi per me fu una piccola croce, che mi ha obbliga ancora oggi a stare allerta come un soldato tutte le volte che faccio un documento importante. E se il documento è composto da molte pagine che vanno firmate ad una ad una c’è di che slogarsi il polso.
Tanto che la burocrazia mi ha perseguitato finora per tutta la vita. Ad esempio: dopo oltre trent’anni dall’entrata in vigore del codice fiscale ho ricevuto una raccomandata, che mi invitava a recarmi all’ufficio anagrafe per firmare il consenso alla rinuncia di tutti i nomi che seguivano il primo, oppure presso l’agenzia delle entrate per farmi rettificare il codice fiscale. Risposi che me ne sarei ben guardato, perché il codice fiscale era quello che usavo da sempre, chissà su quanti e quali documenti compariva, col rischio cambiandolo di trovarmi in un mare di guai col fisco. Quanto ai nomi, dopo quello che avevo finalmente scoperto, mai e poi mai ci avrei rinunciato. Emilio e Paolo erano stati entrambi uomini sfortunati, che avevano vissuto una vita troppo breve e avevano quindi diritto ad essere ricordati almeno in quel modo. Così risposi all’ufficiale dell’anagrafe che facesse lui e poi che mi facesse sapere. Ma è risaputo che i dipendenti pubblici non amano assumersi responsabilità e non ne ho più saputo niente.
Ma quello comunque non era certo il primo “incidente” con l’anagrafe. Quando compii quattordici anni andai a fare il mio primo documento, che mi sarebbe servito per guidare il motorino. A quell'età la carta dì identità non si poteva ancora fare, quindi mi avrebbero rilasciato un foglio protocollo scomodissimo da piegare dieci volte per farlo stare nella tasca dei pantaloni, con tutti i dati e naturalmente la fotografia. Andai con mia madre, ma a ritiralo mi fu concesso d’accordo con gli impiegati di poterlo fare da solo. Si trattava di una città non troppo grande e ci conoscevano tutti. Quando venne l’atteso giorno tornai a casa tutto contento e lo feci vedere trionfalmente a mia madre. Lo lesse, notai un live sussulto e si fece seria. Mi disse: “Ma da quand’è che ti chiami anche Paolo?”
Risposi: “A me lo chiedi? Me lo avete messo voi quel treno di nomi!”
Venne la sera, mio padre rincasò tardi come accadeva spesso. Lei gli chiese spiegazioni su quel nome imprevisto. Lui non rispose se non con un rumore a bocca chiusa, come faceva sempre quando non intendeva dare spiegazioni. Ma si guardarono e si sorrisero capendosi al volo, come facevano quando trattavano di “cose da grandi” che i figli non era conveniente che sapessero. Quella categoria di cose era piuttosto ampia. Non si parlava della guerra, mai. Non si parlava di certi malumori coi parenti. Men che meno di questioni di interessi, del valore delle cose e di quanto era costato questo o quello. I bambini dovevano sapere solo le cose da bambini, ma questa regola rimase ferrea per sempre, anche dopo che i bambini erano ormai maggiorenni.
Quella sera andai a letto contento, avevo il mio documento e la cosa mi faceva sentire grande. Di Paolo mi dimenticai subito senza farmi troppe domande, la regola era la regola, e poi a quell’età erano più importanti i motorini. Gli anni passarono e io mi ritrovai seduto nello spoglio corridoio comunale altre volte. Arrivò una figlia che ebbe poca fortuna perché visse solo qualche ora. Poi un altra ancora e fu l’ultima. il nostro dovere verso Dio e verso la Patria, ma anche verso Darvin e Mendel lo avevamo fatto.
Poi venne il giorno che la mamma si ammalò, e nel giro di una estate ci lasciò sotto i ferri di una equipe chirurgica impegnata in un ultimo disperato tentativo. Il caso era talmente critico che lo filmarono a beneficio della ricerca universitaria, quello fu il suo modo di finire una vita non proprio normale. Durante l’inevitabile sequela di adempimenti burocratici che ne seguì (ancora, nascere e morire sotto quet'aspetto è complicatissimo) una sera ci trovammo insieme fratelli e sorelle, per riordinare le idee e le carte. Ognuno si era dato un compito: stilare una lista delle cose da fare, vedere eventuali scadenze, riordinare gli armadi, scegliere qualche ricordo da regalare alle sue amiche più intime. Io mi ero messo a frugare in un cassetto dove sapevo che c’erano dei documenti, al più bollette e qualche vecchia foto. Mi ritrovai in mano una busta arancione con diverse vecchie carte. Qualche tessera dei tempi della guerra, fogli dattiloscritti nello stile retorico di quei tempi, una piccola mappa catastale e poco altro. Cominciai da un vecchio libretto color verde militare, lo aprii, l’intestazione diceva:
Modello 56-CMINISTERO DEL TESORO
Direzione generale delle pensioni di guerra
Certificato di iscrizione n° xxxxx
Intestato a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Il cognome non mi diceva niente, ma il nome era quello di mia madre, che era abbastanza insolito per trattarsi di un semplice caso di omonimia. Giro la prima pagina e c’è una foto, è lei, con la sua divisa da crocerossina.
Eccolo il Paolo. Mia madre era vedova di guerra quando conobbe mio padre e lui mi mi mise il suo nome per un semplice riguardo, senza farne parola con nessuno, nemmeno con la moglie. Chi era ho dovuto saperlo per caso, nel 1987, dopo trentatre anni che portavo quel nome senza saperne l’origine e dopo quarantaquattro anni dalla sua morte. Me ne andai con quelle carte ingiallite dai fratelli, le buttai sul tavolo e chiesi a bruciapelo:
“Voi lo sapevate?”
Ma fu un cadere dalle nuvole generale, bocche aperte e stupore. Il primogenito fece un rapido calcolo mentale per capire se eravamo tutti figli dello stesso padre, ma si tranquillizzo subito, era nato otto anni dopo quel decesso.Tra i documenti c’è anche un foglio di carta velina dattiloscritto, che racconta come andò:
RELAZIONE REDATTA DAL GRAND’INVALIDO DI GUERRA MARCHIONNI GIUSEPPE DA SANT’ANGELO IN VADO (PESARO), INERENTE IL DECESSO DEL SOLDATO MERELLO PAOLO, AVVENUTO AL LARGO DELLE ACQUE DEL MAR EGEO A CIRCA 50 MIGLIA DA CAPO SPADA IL GIORNO 18 OTTOBRE 1943, ALLE ORE 22,45 IN SEGUITO ALLO SCOPPIO DI UNA BOMBA LANCIATA DA EREO-SILURANTI INGLESI SULLA NAVE “S I N F R A”, OVE ERANO IMBARCATI CIRCA 5000 SOLDATI, DIRETTA A DESTINAZIONE IGNOTA DAI TEDESCHI.Il soldato Paolo Merello apparteneva al 29° battaglione artiglieri – 2° compagnia – P.M. 151 Creta. Da poco tempo era rientrato al corpo in seguito alla contrazione di matrimonio per cui gli fu concesso un mese di licenza. Il suo padre, secondo suoi riferimenti, si trovava in America e sua mamma era proprietaria o affittuaria di un albergo. Dopo la capitolazione dell’8 settembre 43 il centro di raccolta prigionieri del genio di Creta era stato stabilito dai tedeschi a Vasillici, ove avevamo e dormivamo sotto la medesima tenda. Verso il 30 settembre 1943 siamo stati trasportati verso la periferia di Candia in un nuovo campo di concentramento, donde il giorno 17, a piedi, raggiungemmo il porto, nel quale in numero di circa 3.000, fummo imbarcati sulla nave Sinfra diretti per destinazione ignota. La sera stessa, all’imbrunire, salpammo; il mattino seguente approdammo in un porto la cui località la ignoro; sulla nave medesima presero posto circa altri 2000 soldati. Da detto porto ripartimmo la sera del 18 ottobre 1943, sempre a destinazione ignota, ed alle ore 22,45 al largo delle acque di Candia e precisamente a circa 50 miglia da Capo Spada, la nave fu attaccata da una formazione di aero-siluranti inglesi. Alla terza ripresa dell’attacco aereo la nave fu colpita a poppa da un siluro, facendola piegare, inclinata per circa 2/3 sott’acqua. In seguito a ciò avvenne lo scompiglio generale. Ad un certo momento io ed il Merello ci trovammo in acqua, ambedue vicini, e senza salvagente facendo resistenza, contro le onde ed il panico, per circa 17 ore. Per lo sforzo eccessivo ad un tratto la gamba sinistra fu quasi immobilizzata da un granchio (sic) ed io avvalendomi delle buone facoltà di nuoto, lo soccorsi massaggiandogli per lunghe ore la gamba che gli faceva male. In tale pericoloso e pietoso frangente egli mi disse testualmente: abbandoniamoci e moriamo come hanno fatto i nostri compagni, tanto io non ne posso più! Io risposi evasivamente distogliendolo da simili congetture. Successivamente ringraziandomi dell’aiuto portogli mi pregò di portare la sua fede di sposo alla moglie, ciò che io non accettai date le circostanze disastrose del momento. Verso le ore 18 del giorno 19 ottobre 1943 vedemmo una barca venire verso di noi, manovrata dai tedeschi. Così lasciammo il legno che ci aiutava a sostenerci e nuotando si cercava di raggiungere la barca di salvataggio. Allora presi dalla speranza ci scambiammo auguri reciproci di salvezza. Negli ultimi trenta metri circa dalla barca, voltandomi indietro per incoraggiarlo, non lo vidi più. Ciò lo attribuisco allo sfinimento delle sue forza. Tale imbarcazione era un mezzo civile dei tedeschi i quali mi riportarono con gli altri superstiti a Candia in carcere, in attesa del processo in seguito a colluttazione avvenuta tra l’equipaggio tedesco ed i soldati durante l’affondamento della nave.
Giuro e dichiaro che quanto sopra descritto corrisponde a verità, e lo assicuro sotto la mia personale responsabilità, disciplinare, penale, e morale.
S. Angelo in Vado lì 14 novembre 1947
IL DICHIARANTE
(Grand’invalido di guerra Marchionni Giuseppe)
Quel verbale era verosimilmente impreciso e confuso date le circostanze, come lo sono d'altronde ancora oggi le notizie storiche, talvolta contraddittorie e certamente alterate per nascondere le numerose responsabilità di quei vergognosi giorni. Ma in linea di massima si sa che in quel tragico naufragio perirono 2000 italiani, oltre a gran parte dell’equipaggio tedesco e a numerosi partigiani greci anch’essi mentre venivano deportati in Germania come prigionieri. Si salvarono in 523, dopo essere stati per più di undici ore in acqua senza salvagente.
L’affondamento fu causato da aereo siluranti inglesi Bristol Beaufighter. La prima bomba, pare, centrò in pieno la ciminiera e raggiunse la sala macchine fermando la nave e lasciandola al buio. Una precisione che solo le odierne bombe “intelligenti” possono avere e probabilmente si tratto di un colpo di fortuna del pilota. Ma nonostante tutto fu una fortuna anche per i naufraghi, almeno quelli sopravvissuti. Perché se pure carica di bombe fino alla linea di galleggiamento la nave miracolosamente non esplose subito e rimase a galla per diverse ore, divorata lentamente da un incendio. Gli inglesi quasi certamente sapevano del carico, che rappresentava un importante obbiettivo bellico, ma anche della presenza di tanti soldati italiani e greci, che ormai a quel punto della guerra erano o alleati o comunque arresi. Ma allora perché? Quella vicenda fece un disastro per numero di vittime grande come quello del Vajont, eppure se ne sa ben poco.
La Sinfra fu costruita a Oslo nel 1929, al momento dell’affondamento aveva 14 anni, che per una nave non sono niente. Aveva due eliche, una rarità per l’epoca, era quindi una unità moderna ma da carico, vale a dire che era dotata di scialuppe di salvataggio appena sufficienti per il suo equipaggio, presumibilmente una ventina di persone. Che infatti vennero riservate agli ufficiali, non solo tedeschi. Ma non tutti morirono per annegamento. Allo scoppio della prima bomba i prigionieri rinchiusi nelle stive si lanciarono su per i boccaporti in cerca di salvezza, ma la gran parte vennero ricacciati indietro a colpi di mitragliatrice (probabilmente si trattò della “colluttazione” a cui accenna il Marchionni). Molti altri, non sapendo nuotare, esitarono fino all’ultimo e vennero uccisi dallo scoppio finale, quando l’incendio raggiunse la polveriera. La Sinfra inoltre non viaggiava da sola ma era scortata da una unità militare tedesca, che però si tenne per lungo tempo alla larga temendo di essere coinvolta nell’esplosione. Altre vittime caddero quando finalmente arrivarono i soccorsi, la maggior parte costituiti da pescherecci, che però avevano l’ordine tassativo di salvare prima i tedeschi e che quindi esitarono a lungo.
Così mia madre, che probabilmente non seppe mai tutti questi particolari e la portata della tragedia, se ne andò senza dir niente ai figli. Col tempo intervistammo i parenti che ovviamente sapevano, ma ci dissero che avevano categorica consegna di tenere la bocca chiusa.
Poco più di un anno fa noi fratelli e mio padre ricevemmo un atto giudiziario. Una convocazione nanti il Tribunale di Chiavari, per definire la procedura d’usucapione di un terreno sito, nientemeno, sul promontorio di Portofino. La procedura era stata promossa da chi aveva posseduto quel terreno da anni, ma i parenti del legittimo proprietario, Paolo Morello, dovevano essere sentiti perché avanzassero eventuali obiezioni. Gli aventi causa eravamo noi, oltre ai superstiti della famiglia Merello. Dopo qualche giorno mio padre mi chiamò al telefono e azzardò una spiegazione. Ormai aveva novantadue anni e per attutire l’imbarazzo gli dissi che sapevamo tutto, e che alla prima occasione ne avremo parlato con calma. Quanto alle decisioni da prendere fu presto fatto: si trattava di un appezzamento minuscolo (quello della piccola mappa rinvenuta nel cassetto dei misteri) situato in un territorio certamente sommerso da molteplici vincoli di inedificabilità. Non sarebbe valsa la pena e in ogni caso gli eredi sarebbero stati almeno una decina, per cui non se ne fece nulla.
Ma purtroppo sfumò anche l’ultima occasione di parlarne con calma, perché dopo qualche mese ci lasciò anche papà, portandosi dietro definitivamente qualunque spiegazione circa quell’assurdo segreto. D'altronde “erano cose da grandi” che bambini ormai vicini ai sessanta era sconveniente che sapessero.
23 marzo 2014





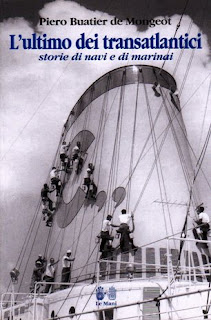


Commenti
Posta un commento